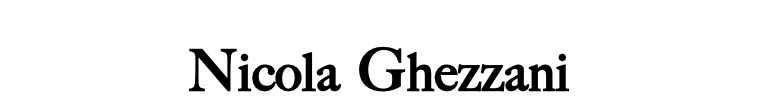La depressione
Il vissuto depressivo
 La depressione è un malessere totale, che pervade l’intero campo della personalità soggettiva. Il depresso sente – talvolta con angoscia, talaltra con gelida disperazione – l’irrimediabile negatività della vita. Tutto è perso, non c’è più nulla da fare, meglio sarebbe se la vita terminasse. Di solito il sintomo depressivo genera nella coscienza soggettiva una tetra e opaca confusione. Ma basta che il terapeuta o l’amico interroghino e lascino il depresso parlare liberamente per rendersi conto che al di sotto di questo velo ottenebrante i pensieri hanno una certa chiarezza.
La depressione è un malessere totale, che pervade l’intero campo della personalità soggettiva. Il depresso sente – talvolta con angoscia, talaltra con gelida disperazione – l’irrimediabile negatività della vita. Tutto è perso, non c’è più nulla da fare, meglio sarebbe se la vita terminasse. Di solito il sintomo depressivo genera nella coscienza soggettiva una tetra e opaca confusione. Ma basta che il terapeuta o l’amico interroghino e lascino il depresso parlare liberamente per rendersi conto che al di sotto di questo velo ottenebrante i pensieri hanno una certa chiarezza.
Ed ecco che il rendiconto depressivo viene alla luce.
In alcuni casi il sentimento di negatività riguarda la propria singola esistenza personale: allora il depresso è schiacciato da sentimenti persecutori di esclusione, minorità, inferiorità, indegnità, colpevolezza. Di fronte al mondo che continua a vivere e ad essere felice, egli si sente un essere infetto, immondo, macchiato da una colpa insopportabile: si sente cattivo, oppure un traditore della fiducia altrui, o un inetto, un incapace, oppure un malato, qualcuno comunque che dovrebbe scomparire dalla faccia della terra. Il pensiero di se stesso, di ciò che lui è in modo intrinseco o per qualche caratteristica acquisita, lo annienta. Il peso della propria autopercezione e della propria autodefinizione diventa insostenibile. L’immagine interna è totalmente negativa.
Ecco l’attenta descrizione che Silvano Arieti fa di questi specifico vissuto depressivo:
«Il bambino [che svilupperà una depressione] sembra ricettivo all’influenza dell’adulto significativo: non ci sono [in lui] tendenze autistiche […] Ma al contrario c’è un’immediata accettazione del mondo simbolico emozionale degli adulti circostanti. Il “Tu” che è l’altro è immediatamente accettato dal bambino, che lo introietta coi suoi simboli e i suoi valori. I genitori si aspettano molto da lui. Il loro atteggiamento generale verso la vita li spinge a evocare nel bambino un precoce senso del dovere, della responsabilità, della colpa. Si ottiene ciò che si merita […]. In molto casi i carichi apparentemente autoimposti conferiscono un senso di particolare infelicità al paziente, che non vede alternative. Inoltre, la necessità di compiacere gli altri genera un sentimento di futilità e di vuoto. Infatti il paziente non dà ascolto ai suoi propri desideri, non sa cosa vuol dire essere se stesso; si sente frustrato, infelice. Ma questi sentimenti di infelicità, futilità e mancanza di realizzazione sono nuovamente male interpretati. Il paziente sente di dover essere rimproverato. Se è infelice, se non trova un obiettivo nella vita, deve esser colpa sua» (Arieti, 1957).
Questa è la variante “autoaccusatoria” della depressione, quella per la quale essa è più conosciuta, che tuttavia nel passaggio alla fase maniacale diventa “rivendicativa”. La depressione rivendicativa dirige l’accusa più violenta al mondo stesso: crudele, ingiusto, orribile; e alla vita stessa: mostruosa, odiosa, senza senso.
In questo caso, il problema non è soltanto lui, il depresso, o forse persino non è affatto lui: è la vita stessa, la vita di tutti, ad essere avvertita come impossibile; e allora ogni aspetto dell’esistenza appare negativo: è l’immagine esterna – la realtà, la vita, il mondo – ad essere compromessa. Il mondo viene avvertito come un luogo torbido e immorale di bassezze e di cattiverie, oppure è una landa desolata e viene percepito nel suo complesso sotto la luce nera di una vera e propria metafisica del dolore e del male. Nei casi più annichilenti, la vita intera è un gioco assurdo e perverso, totalmente privo di senso; l’individuo si sente isolato da tutto e da tutti e sospeso su un vuoto assoluto. Tutto appare terribile, e, soprattutto, irrimediabile. In questa tipologia depressiva, non c’è alcuna luce, nemmeno nella vita degli altri.
In entrambi i casi (quello autoaccusatorio e quello rivendicativo), il vissuto sintomatico non dà conto della realtà oggettiva e immediata, ma delle interpretazioni che l’individuo dà di essa. Anche nelle autoaccuse il depresso non dà voce alle ingiunzioni e alle condanne del suo ambiente parentale, ma al sistema di credenze interiorizzato (il Super-io), che ha preso ormai vita autonoma. È dunque in gioco una «ideologia precedente, una maniera di vedere se stessi nella vita» (Arieti, 1980, p. 21) che filtra il rapporto con la vita e genera la depressione. Lo stato patologico ha dunque bisogno di una intelaiatura cognitiva, cioè di valori e credenze apprese nell’infanzia «ma che hanno continuato ad accrescersi durante il resto della vita» (ibidem).
Il più delle volte (quando non abbia subito traumi particolarmente oggettivi e gravi) il depresso è vittima della sua stessa sensibilità empatica, che gli ha fatto interiorizzare i valori familiari, e della sua sensibilità morale, che fa sì che egli giudichi se stesso e il mondo sulla base dei valori introiettati, che egli ha portato alla massima potenza per via del suo perfezionismo. A dimostrazione che colui che ammala nella psiche è il più delle volte un individuo iperdotato per ciò che attiene ad alcune delle funzioni psichiche più specificamente umane.
Infine, quando è depresso, l’individuo oscilla fra stati di ansia catastrofica, in cui tutto sta per essere perso, e stati di depressione cupa, nella quale ci si abbandona a corpo morto e tutto appare infine senza rimedio. Ma qualche volta, quando lo spirito non è del tutto domato, quando cioè si attiva il bisogno di opposizione, si affronta la depressione come una belva in gabbia, cioè con ossessivi pensieri di liberazione mediante suicidio. Molti dei suicidi che nascono da una sfida eccitata e maniacale nei confronti della vita e del mondo fanno capo a vissuti gravemente depressivi.
Cenni storici
 Quella che noi oggi chiamiamo genericamente depressione, al tempo della medicina greco-romana, la medicina ippocratica, andava sotto il poetico nome di “melancolia”, poi latinizzato col termine “melanconia”. La parola derivava dal greco, dalla composizione di mélan e cholè, da mélas (neutro: mélan) e cholè, ossia “nero” e “bile”, e dunque “umore nero” o – come si diceva un tempo – “atra bile”.
Quella che noi oggi chiamiamo genericamente depressione, al tempo della medicina greco-romana, la medicina ippocratica, andava sotto il poetico nome di “melancolia”, poi latinizzato col termine “melanconia”. La parola derivava dal greco, dalla composizione di mélan e cholè, da mélas (neutro: mélan) e cholè, ossia “nero” e “bile”, e dunque “umore nero” o – come si diceva un tempo – “atra bile”.
Ciò che per noi oggi ha valore di metafora – l’essere di “umore nero” – rappresentava nelle epoche classiche una nozione di tipo scientifico. La melanconia veniva, infatti, attribuita ad una discrasia, cioè ad uno squilibrio degli umori i cui flussi si riteneva regolassero le emozioni e il rapporto dell’individuo col mondo. Si parlava pertanto di “umore nero”, nel senso della circolazione nell’organismo di una bile nera o atrabile, il cui stato, fluttuante dal ghiacciato al bollente, produceva lo squilibrio del melanconico (la melanconia, divenuta poi malinconia per assonanza e analogia con il termine e il concetto di “male”).
Nell’antica concezione psicosomatica – non genetica – della melanconia era già presente il nocciolo della teoria dialettica. Come osserva un noto neurobiologo contemporaneo, Jean-Didier Vincent:
«Il ruolo della bile nera nella genesi di una affezione mentale fornisce il primo esempio di relazione causale fra un disordine psichico e un’anomalia psichica, ossia fra uno squilibrio biochimico e una affezione della psiche» (1998, pag. 21).
È quanto meno singolare il fatto che nozioni di una certa epoca, apparentemente non scientifiche o classificate da un’epoca successiva come mere superstizioni, possano poi, nel corso dei secoli, rivelare un nocciolo di verità. Per almeno un secolo la psichiatria ottocentesca si è ossessionata sul concetto di “degenerazione nervosa”, intendendo con questa definizione uno stato degenerativo irreversibile dei tessuti nervosi, a partire dai neuroni. Questa concezione “organicistica” (che sottintende che in ogni patologia psichica la malattia sia dell’organo, quindi che esista una anomalia biologica intrinseca) ha portato a “illusioni scientifiche” come quella di rinvenire prima o poi il “virus” della schizofrenia o, oggi, il gene, o il sistema poligenico, intesi come causa unica di tutte le disfunzioni psicologiche. Per contro, la seconda metà del Novecento appare impegnata nel recupero dell’antica nozione di “umori”, i cui equilibri e squilibri starebbero, in quest’ottica, alla base sia della psicogenesi delle emozioni che della psicopatologia. In neurobiologia, in effetti, si parla di ormoni e neuro-trasmettitori dalla cui dinamica derivano sia gli stati emotivi di base, sia le fluttuazioni e le discontinuità dei “cicli umorali”.
L’ipotesi che alla base della depressione vi sia una alterazione psicosomatica, cioè che gli stati dell’umore derivino da squilibri biochimici cerebrali, è avvalorata dalle osservazioni scientifiche; ma è suscettibile di due diverse interpretazioni.
Alcuni studiosi individuano le cause del disturbo in una base genetica malata; ma se ciò fosse vero occorrerebbe spiegare come mai il 20, 30 percento della popolazione presenterebbe alterazioni patologiche del DNA, una proporzione inaudita per qualunque altra malattia umana. Altri, tra cui io stesso, abbracciano un’ipotesi dialettica, ossia che squilibri di carattere emotivo psicologico, più o meno antichi e profondi, sortiscano un effetto di trascinamento psicosomatico sulle strutture nervose, alterando i flussi biochimici e i circuiti neuronali – come dimostrano le analisi biochimiche e strumentali – ma non in modo irreversibile.
Dal punto di vista dialettico, prima viene il vissuto psicologico alterato, poi questo vissuto altera pian piano la struttura biochimica e le reti neurali preposte all’emozione, alla ideazione e alla volizione. Cioè depressi non si nasce, ma si diventa.
Lo statuto biologico della depressione
 La nozione di squilibrio umorale implica una dialettica fra mente e corpo che consente di formulare, a proposito della depressione, una ricca ipotesi psicogenetica.
La nozione di squilibrio umorale implica una dialettica fra mente e corpo che consente di formulare, a proposito della depressione, una ricca ipotesi psicogenetica.
Prima fase
eventi negativi inducono emozioni che sono stati psicosomatici complessi, costituiti simultaneamente
– nella mente: da un costrutto cognitivo e da un sentimento;
– e nel corpo: da fenomeni biochimici.
Seconda fase
tali eventi sono trattenuti nella memoria come struttura neurologica, coi flussi biochimici correlati.
Terza fase
la memoria mantiene costante l’emozione dolorosa (sensi di colpa, di condivisione del dolore, bisogni auto-punitivi ecc.) per scopi inerenti la stabilità strutturale della personalità.
È dunque possibile concepire e dimostrare in termini scientifici che la genesi della depressione, come anche della ciclicità maniaco-depressiva, risiede in una causalità psicologica conservata nella memoria psicosomatica e utilizzata per mantenere attivi processi dolorifici di tipo mentale e biologico.
La depressione e il senso di colpa
 Come ho mostrato nel mio libro Volersi male, ho verificato ormai infinite volte che la depressione coincide con un’intima “volontà” soggettiva di mantenere stabilmente l’Io in una condizione di sottomissione e di dolore, che annulli l’impulso di opporsi con la rabbia a una limitazione avvertita del diritto di vivere nella libertà e nella gioia. In sostanza, la depressione è un inconscio attacco autopunitivo che mira a colpire le proprie istanze di protesta rabbiosa. L’io vivente del soggetto depresso è giudicato dal suo stesso inconscio come carente o colpevole, e come tale condannato ad un lenta morte per auto-soppressione.
Come ho mostrato nel mio libro Volersi male, ho verificato ormai infinite volte che la depressione coincide con un’intima “volontà” soggettiva di mantenere stabilmente l’Io in una condizione di sottomissione e di dolore, che annulli l’impulso di opporsi con la rabbia a una limitazione avvertita del diritto di vivere nella libertà e nella gioia. In sostanza, la depressione è un inconscio attacco autopunitivo che mira a colpire le proprie istanze di protesta rabbiosa. L’io vivente del soggetto depresso è giudicato dal suo stesso inconscio come carente o colpevole, e come tale condannato ad un lenta morte per auto-soppressione.
Detto in termini psicodinamici, c’è un Super-io, cioè una coscienza morale, che attacca con continue denigrazioni e svalutazioni l’Io soggettivo, per colpe vere o presunte.
Ciò può accadere per via di sensi di colpa espliciti o sottili e impliciti: colpa nei confronti di qualcuno o qualcosa di cui si è violata l’esistenza, o di fronte ai quali non si è nel diritto di condurre una vita felice; o colpa nei confronti di ideali che si sarebbero dovuti raggiungere e invece sono stati “traditi”.
La depressione, in questo senso, si rivela come una vera e propria “malattia morale”, interamente vissuta sul piano del giudizio. Spesso il soggetto depresso sente di aver tradito un ideale sociale, per esempio di non essere stato all’altezza delle aspettative dei genitori o sue stesse; altre volte di aver tenuto un atteggiamento rabbioso e distruttivo verso persone altrimenti amate; altre volte ancora, di essere deluso dalla vita e per questo di odiare il mondo, di provare invidia verso i più fortunati (o presunti tali), di essersi separato dal genere umano. E tutto questo gli si ritorce contro in termini di colpa, in un loop di rabbia e di punizione da cui non riesce a uscire.
Esempi e cenni terapeutici
 A livello giovanile, la depressione dipende spesso dall’idea di avere tradito le aspettative di qualcuno: dei genitori, degli insegnanti, del gruppo dei pari. Mentre un tempo il ragazzo la ragazza andavano in depressione perché tradivano la fiducia dei genitori, oggi più spesso sono coinvolti da insegnanti troppo esigenti o ancora più spesso dal gruppo dei pari che chiede l’assunzione di modelli che il giovane non riesce a incarnare. A questo livello, spesso la depressione è mascherata da comportamenti sfidanti, dall’assunzione di alcol o di droghe o da un sempre più diffuso autolesionismo fisico.
A livello giovanile, la depressione dipende spesso dall’idea di avere tradito le aspettative di qualcuno: dei genitori, degli insegnanti, del gruppo dei pari. Mentre un tempo il ragazzo la ragazza andavano in depressione perché tradivano la fiducia dei genitori, oggi più spesso sono coinvolti da insegnanti troppo esigenti o ancora più spesso dal gruppo dei pari che chiede l’assunzione di modelli che il giovane non riesce a incarnare. A questo livello, spesso la depressione è mascherata da comportamenti sfidanti, dall’assunzione di alcol o di droghe o da un sempre più diffuso autolesionismo fisico.
Sempre in età giovanile, la depressione può dipendere anche da una mancata integrazione sociale. Il ragazzo o la ragazza non trovano il partner giusto, non riescono negli studi, non si integrano nel gruppo dei pari, stentano a individuare il percorso sociale da intraprendere.
Le depressioni dell’età adulta sono le più insidiose, perché possono cronicizzare. Riguardano l’intero assetto della personalità e il rapporto generico con l’intero mondo sociale. Tipico l’esempio del cinquantenne che perde il lavoro e non sa come riciclarsi. O del responsabile di una famiglia in difficoltà che, in rivolta contro le ingiustizie del mondo del lavoro, si rende impossibile continuare a lavorare e a mantenere la sua famiglia.
Altro esempio, l’individuo sensibile – spesso un introverso riflessivo – che ha subito torti dalla vita e che reagisce ad essi con un confuso odio verso l’intera umanità. Questo odio gli viene imputato dal Super-Io come segno non della sua sensibilità, ma della sua indegnità, in un processo che lo può portare all’annichilimento.
Se non si smonta l’apparato accusatorio e la rabbia sepolta che lo alimenta, la depressione non cede nemmeno agli psicofarmaci. Questi possono dare un temporaneo sollievo e qualche volta mostrare la vita sotto una diversa angolazione. Ma se non sono efficaci – e lo sono sempre solo per caso, non potendo prevedere mai la variabile soggettiva – allora occorre aumentarne i dosaggi o cambiarli, con effetti imprevedibili. Quindi, la depressione si cura più sul piano psicoterapeutico che su quello farmacologico (ferma restando l’utilità del farmaco nelle situazioni emergenziali): innanzitutto analizzando gli ideali che il depresso si è posto, spesso irraggiungibili o comunque non realistici; quindi facendo emergere la rabbia repressa e il terribile senso di colpa associato; infine smontando l’attrezzatura ipercritica della sua coscienza morale.
Tutti e tre i passaggi sono fondamentali; ma il secondo è il più importante. La depressione dipende sempre da rabbia sepolta, anche quando questo non appare alla coscienza. Può essere una rabbia molto antica e strutturata nella personalità; oppure riferita a eventi recenti. Di solito, quando sfugge alla coscienza, ciò dipende dalla sua antichità o da una rimozione che impedisce di ammetterla e di vederla.
Risolto il velo di tenebra, al di là della depressione si scoprirà che esiste un mondo nel quale la condanna alla mortificazione perpetua non solo non ha fondamento, ma era il frutto di una rabbia morale e di una conseguente autocritica esasperate, persino spietate; era il frutto di una guerra intestina non pacificata, che può risolversi nel flusso generale della vita.
Insomma, se siamo individui sensibili, ci possiamo liberare dagli altri solo attraverso gli altri, con loro, grazie alla condivisione dei beni e dei mali, non contro di loro. L’unica possibilità che abbiamo su questa terra è essere di aiuto reciproco, solidarizzare e presentare i nostri bisogni all’intelligenza dell’Altro, di un mondo sociale e culturale multiforme e vasto, nel quale occorre trovare il proprio posto, la propria individuazione.
Se non si accetta questo processo, al soggetto non resta che infuriarsi, odiare, separarsi dagli altri, con l’effetto di precipitare nei sensi di colpa e nella depressione. Il depresso ha commesso l’errore di porsi con rabbia contro qualcuno in realtà amato o contro tutti; errore pagato con la separazione dagli altri (una profonda solitudine) e il senso di morte interiore (la condanna).
Vedere l’errore commesso è già cominciare a guarire.
Bibliografia
Arieti S. (1957), The Decline of Maniac-Depressive Psychoses: Its significance in the Light of Dynamic and Social Psychiatry. Dattiloscritto, in Passione R. La forza delle idee, Silvano Arieti, una biografia, Mimesis, 2020).
Arieti S., Depressione grave, in “Rivista psichiatrica”, 11, 1980.
Jean Didier Vincent, Biologia delle passioni, Einaudi, Torino, 1988.
Nicola Ghezzani, Volersi male, FrancoAngeli, Milano, 2002.
Nicola Ghezzani
Psicologo clinico, psicoterapeuta
formatore alla psicoterapia
Contattalo con un messaggio su WhatsApp al 333 999 4797
o per e-mail: nic.ghezzani@gmail.com
Indirizzo Skype: nicola.ghezzani.psicologo