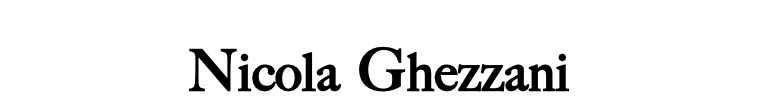Psicoterapia dell’ansia e delle fobie
L’ansia come reazione istintuale di base
 Per comprendere appieno cos’è l’ansia (e l’attacco di panico, che dell’ansia è solo la massima espressione) occorre partire dal dato di fatto che si tratta di uno stato emotivo iscritto nel nostro corredo neurobiologico animale.
Per comprendere appieno cos’è l’ansia (e l’attacco di panico, che dell’ansia è solo la massima espressione) occorre partire dal dato di fatto che si tratta di uno stato emotivo iscritto nel nostro corredo neurobiologico animale.
Chiunque avrà visto un cane che rizza le orecchie nel percepire un rumore forte e indefinito. L’animale ha avvertito nel mondo esterno un segnale minaccioso, ma non riesce a identificarlo, quindi piuttosto che paura (che è la reazione emotiva di risposta alla precisa individuazione di un pericolo) egli prova ansia: uno stato di allerta relativo a un’area generica e indefinita di pericolo.
A questo livello l’ansia è la disposizione psicosomatica (il corpo è il primo soggetto di reazione della vita mentale) in cui un organismo si pone per classificare un segnale che sembra indicare un pericolo. Un rumore improvviso, lo scuotimento di una sterpaglia, un gesto imprevisto di un essere umano o di un altro animale ed ecco che il cane rizza le orecchie, si immobilizza e resta in attesa oppure prende ad abbaiare in direzione della fonte del segnale. Il cane non sa affatto quale sia la “realtà” contro cui si sta impegnando, ma reagisce al segnale che indica la mera possibilità di un pericolo. In lui si attivano all’istante sia il sistema nervoso autonomo (egli “scatta”) sia il sistema neuroendocrino (che rilascia nell’organismo gli ormoni dell’allerta e dell’attivazione).
 L’ansia è, dunque, in prima istanza, una paura differita, un’emozione che segnala all’organismo istintuale – tanto animale che umano – la presenza di segni di pericolo, di un pericolo, tuttavia, non ancora definito.
L’ansia è, dunque, in prima istanza, una paura differita, un’emozione che segnala all’organismo istintuale – tanto animale che umano – la presenza di segni di pericolo, di un pericolo, tuttavia, non ancora definito.
Assunta in questa sua manifestazione di base, l’ansia è un’emozione previsionale, nel senso che è parte di un processo neurofisiologico di previsione, quindi presuppone la capacità di valutare il futuro. L’animale “si prepara” ad affrontare una minaccia di cui ha, per ora, solo indizi vaghi.
Di quali pericoli può avere paura un animale? In linea di massima, direi che sono due.
Il primo è l’avvistamento di un predatore, sia di altra specie che conspecifico. Secondo la sua storia evolutiva l’unico predatore è di altra specie; ma per la sua storia sociale l’animale può “sapere” che anche il simile può diventargli nemico: per esempio, in situazioni di costrizione o sovraffollamento il singolo animale o l’intero branco reagiscono con lo stress, quindi con potenziali reazioni aggressive da un lato e di allarme dall’altro.
Il secondo pericolo da cui può difendersi è la percezione di un imminente cataclisma naturale. Un colpo di vento, il movimento improvviso di uno stormo di uccelli, un rapido incremento del calore, un odore di fumo o di umidità o anche una sensazione epidermica di elettricità… Qualcosa di anomalo indica l’imminenza di un temporale, di un incendio, di un terremoto…
In entrambi i casi, l’animale si predispone ad agire secondo le modalità difensive tipiche di ogni animale: l’attacco, o – più spesso – la fuga.
Altra caratteristica di base: come ogni meccanismo istintuale, l’ansia è un’emozione aut-aut: nel senso che o c’è o non c’è, e quando c’è è inesorabile: manifesta tutto il suo repertorio di sintomi fino a raggiungere un acme, un punto di massima intensità a partire dal quale comincia la sua discesa.
L’ansia come fenomeno umano
Relativamente alle emozioni di base, l’uomo è un comune animale e, di fronte a un pericolo, reagisce allo stesso modo di ogni altro animale. Se individua il pericolo ha paura; se invece, pur avendone l’intuizione, non riesce a metterlo a fuoco, prova ansia. La memoria che in situazioni analoghe c’è stato pericolo effettivo lo mette in una condizione di stress e meno riesce a capire di che natura sia il pericolo, più la sua reazione di stress è rilevante, col rischio di un sovra-eccitamento ansioso col possibile esito di una reazione di panico, o dell’esaurimento delle risorse energetiche col possibile esito di una inibizione funzionale o depressiva, del crollo delle difese immunitarie, di disfunzioni neuroendocrine e malattie organiche.
Esiste tuttavia una differenza fondamentale fra il mondo di un animale e il mondo di un essere umano, che gran parte degli studi clinici di tipo psichiatrico organicista e comportamentista non osservano. I due mondi sembrano uguali a chi adotta una posizione empirica ingenua; in realtà sono del tutto diversi. Qual è questa differenza che separa in modo sostanziale il mondo di un essere umano da quello di un animale? Ebbene, la differenza sta nel fatto che l’uomo vive immerso in un universo mentale rappresentato (composto di memoria, immaginazione e di segni e simboli che integrano il tessuto cognitivo), mentre l’animale vive perlopiù di schemi istintivi, ossia di memorie filogenetiche iscritte nel DNA, e di memorie soggettive limitate e perlopiù di scarsa complessità. La differenza è sostanziale: l’uomo vive in rapporto a oggetti mentali più di quanto non viva in rapporto a oggetti fisici e quindi a schemi comportamentali – oggetti mentali della cui esistenza oggettiva è sempre possibile dubitare.
Se una gazzella fugge all’avvistamento di un predatore, possiamo essere certi che il predatore esiste: milioni di anni di evoluzione, iscritti nel DNA, certificano della realtà del segnale, anche se talvolta il segnale confonde una realtà per un’altra e la gazzella, per esempio, si ritrova a dare uno scarto di fronte a un bufalo come se fosse un predatore. In natura vediamo spesso episodi del genere: uno stormo di uccelli fugge al rumore di un’auto nella boscaglia; un cane ringhia alla mano di un uomo di buone intenzioni. In questo caso la natura preferisce sbagliare per eccesso piuttosto che per difetto: se in quell’auto ci fossero dei bracconieri o l’uomo che si avvicina al cane fosse un brutale seviziatore di animali, l’istinto in apparenza grossolano avrebbe avuto ragione.
Nel caso dell’uomo, mentre è istintivo che egli fugga di fronte a un serpente, lo è decisamente meno se ha paura di una strada dove gli è stato detto sia avvenuto un delitto o di fronte a una gabbia aperta ma vuota o a un segnale stradale di “pericolo serpenti” o “pericolo caduta massi”. Nel primo caso si tratta del ricordo di un racconto, negli altri casi si tratta di un simbolo. Da ciò deriva, in rapporto all’ansia, una conseguenza di grande rilievo: l’uomo può vivere emozioni di allarme non solo in rapporto al (cosiddetto) mondo reale, ma anche – cosa impossibile per l’animale – in rapporto al mondo delle rappresentazioni mentali.
L’ansia come fenomeno simbolico
 Un uomo può provare ogni sorta di emozioni e sentimenti, quindi anche ansia, al solo ricordo di un’esperienza, oppure nell’immaginarla, e persino – e questo è fondamentale per capire il nostro discorso – qualora egli entri in contatto col simbolo di essa.
Un uomo può provare ogni sorta di emozioni e sentimenti, quindi anche ansia, al solo ricordo di un’esperienza, oppure nell’immaginarla, e persino – e questo è fondamentale per capire il nostro discorso – qualora egli entri in contatto col simbolo di essa.
Un esempio. Un ragazzo si trova a passare per un via buia: ricorda di aver subito un giorno, nello stesso luogo, un’aggressione e prova ansia; oppure immagina che il buio di quel luogo sia favorevole a un’aggressione e prova ansia; o ancora in un corridoio illuminato e affollato passa accanto a una tenda nera, simbolo di ciò che può essere nascosto, e prova ansia. L’uomo dunque, unico fra gli animali, può vivere la paura di qualcosa che non è presente nel campo reale, ma è invece presente nel campo delle rappresentazioni mentali. Nei due famosi casi di fobia descritti da Freud, il piccolo Hans e il caso dell’uomo dei lupi, entrambi i pazienti avevano sviluppato una zoofobia nei confronti di specifici animali che rappresentavano in realtà membri e situazioni della loro famiglia: quindi, benché fosse del tutto naturale che un bambino potesse avere paura di grosso cavallo e un uomo adulto di un branco di lupi (sia pure in sogno), le due paure erano ipnogene e ridondanti e rimandavano ad angosce e proibizioni relative alla vita familiare. Benché l’interpretazione che ne diede Freud sia oggi del tutto opinabile, le due storie cliniche continuano ad avere un valore emblematico.
 Da questo semplice fenomeno spesso psichiatri organicisti e psicologi comportamentisti deducono che il sintomo è neutro, nel senso che è una sorta di risposta a vuoto: manca l’oggetto reale di cui aver paura, dunque il sintomo riflette non già di un processo cognitivo bensì di una mera disfunzione neurologica (in sostanza: è un sintomo “stupido”). Secondo loro il ragazzo che prova ansia alla vista della tenda nera, oppure la ragazza che prova ansia non appena si trova su una vasta piazza cittadina, non stanno reagendo a un “simbolo” (nero = pericolo nascosto; piazza = libertà di agire); ma “esagerano” nella reazione di allarme perché il loro cervello ha un difetto meccanico e secerne i neurotrasmettitori sbagliati.
Da questo semplice fenomeno spesso psichiatri organicisti e psicologi comportamentisti deducono che il sintomo è neutro, nel senso che è una sorta di risposta a vuoto: manca l’oggetto reale di cui aver paura, dunque il sintomo riflette non già di un processo cognitivo bensì di una mera disfunzione neurologica (in sostanza: è un sintomo “stupido”). Secondo loro il ragazzo che prova ansia alla vista della tenda nera, oppure la ragazza che prova ansia non appena si trova su una vasta piazza cittadina, non stanno reagendo a un “simbolo” (nero = pericolo nascosto; piazza = libertà di agire); ma “esagerano” nella reazione di allarme perché il loro cervello ha un difetto meccanico e secerne i neurotrasmettitori sbagliati.
La Psicologia dialettica ha tutt’altro punto di vista. Secondo noi, il sintomo è una reazione del tutto intelligente e funzionale; nello specifico, l’ansia nasce dalla percezione (il più spesso non cosciente, ma attiva in modo inconscio) di una rappresentazione simbolica di una realtà temuta. Forse è lo psichiatra a non possedere un intelletto all’altezza, ossia in grado di decriptare il processo di referenza simbolica che sta nel rapporto fra una rappresentazione e una cosa. Detto in termini un po’ estremi: un uomo che non capisce le metafore non può capire un sintomo psicopatologico. Se uno psichiatra non capisce che “nero” è un colore ma è anche un simbolo – e lo è dall’alba dei tempi – che sta a indicare l’oscuro, il nascosto, il triste, il pericoloso (tanto che nella nostra cultura è associato alla morte e al lutto), e non capisce che “piazza” è un luogo fisico, ma è anche un simbolo di ampiezza, libertà, luogo di incontro e dibattito, allora può riconsegnare la sua laurea e fare il farmacista (o limitarsi a fare il neuro-farmacologo, senza discettare di psicopatologia).
La differenza fondamentale fra il mondo di un animale e quello di un essere umano, che fa divergere i due mondi, è che l’animale – anche nel caso degli animali sociali – vive in un mondo di reazioni istintuali codificate nel DNA, quindi in un mondo concreto limitato, privo del moltiplicatore infinito costituito dalla rete simbolica; l’uomo invece vive immerso in una complessa rete simbolica prodotta dalla non meno complessa realtà sociale e dalla capacità, unica nel mondo biologico, di interagire con il mondo dei segni creando simboli sempre più inclusivi. Quindi l’uomo può aver paura non solo degli altri esseri umani, ma anche dei simboli che li rappresentano, in un modo affatto diverso da come un cane ha paura di altri cani o un gatto di altri gatti. L’uomo può avere paura in rapporto a segni e oggetti mentali: ai ricordi, all’immaginazione e ai simboli del suo rapporto con gli altri esseri umani.
E poiché è avvolto da questa rete di significazioni simboliche, la quale ha assunto nel corso della sua evoluzione biologica un’importanza almeno pari a quella della rilevazione di segnali del mondo fisico, la specie Homo ha ricodificato le emozioni istintuali di ansia da avvistamento di un predatore e di ansia da percezione di una catastrofe con significati umani: l’uomo prova ansia all’intuizione che un altro essere umano o un gruppo o la società nel suo complesso possano rivelarsi per lui come un predatore (cioè aggressivi e distruttivi) e comportare la catastrofe sua e/o delle persone amate.
In sintesi, un individuo umano prova ansia (anche psicopatologica) in relazione all’azione che un simbolo (un significante conscio o inconscio) esercita su di lui; posto che questo simbolo rimandi a una relazione umana fondamentale. La pericolosità della situazione, per quanto varia nella sua fenomenologia, rimanda a un riflesso elementare: tutti i bambini privati di colpo del supporto di sostegno (umano o artificiale) reagiscono coi sintomi e la neurochimica dell’ansia1.
In tal senso, l’ansia a livello umano non fa altro che segnalare il pericolo in cui incorre il soggetto umano nel momento in cui teme di essere privato del legame di riferimento, sia esso il legame affettivo primario che il legame sociale di riferimento; e ciò per i motivi che mi accingo a spiegare.
L’ansia come fenomeno sociale e sintomo funzionale
In alcuni tipi di ansia strutturata (fobia) la tesi sin qui avanzata è del tutto evidente. Pensiamo all’ansia sociale e, per fare un esempio, assumiamo di questa una variante molto comune: l’ansia da prestazione o da giudizio. L’individuo sociofobico ha paura di essere giudicato inadeguato, insufficiente o comunque negativo da un giudice o un “tribunale” che gli si presenta nella mente: il professore che lo interroga, il gruppo dei pari, il gruppo dei parenti, il superiore di grado in ufficio, il pubblico che ascolta una sua relazione… L’oggetto della fobia è l’annichilente sensazione di svelare una identità inadeguata al suo contesto sociale di riferimento.
La figura giudicante è da lui avvertita come un potenziale predatore – un’entità neutra o familiare che gli si rivela come nemica – e il momento in cui questa autorità interiore lo giudicherà un individuo inetto e incapace sarà per lui una catastrofe psicologica e sociale. Da qui l’angoscia sociale.
Esistono però fobie che in apparenza sfuggono a questa classificazione. L’ipocondria esprime la paura ossessiva delle malattie e della morte; l’agorafobia indica la paura dello spazio aperto o vuoto: che c’entrano queste ansie con la realtà sociale?
In numerosi studi e in tutti i miei libri sull’argomento2 ho mostrato che anche le fobie in apparenza più bizzarre rimandano alla paura di essere mal giudicati, condannati e penalizzati da coloro che per noi sono gli esseri umani più importanti. E ciò perché, più in profondità, esse rimandano sempre a un conflitto psicologico, più o meno cosciente, in rapporto al quale il soggetto teme di porre in essere pensieri o atti incompatibili la sua identità morale e di essere perciò mal giudicato e, al limite, condannato e escluso dalle persone per lui importanti. In relazione a quest’angoscia il sintomo si rivela funzionale a mantenere l’ordine pregresso, che non dovrà essere violato.
Faccio degli esempi. Un esempio di ipocondria, la paura di ammalare e morire. Un ragazzo vive con l’anziana madre in un regime di stretta simbiosi affettiva. Vorrebbe essere più libero e non condizionato dai rituali tipici delle persone anziane. Forse, il legame fra loro riflette di un’antica e ormai insopportabile simbiosi regressiva. Tuttavia, allo stesso tempo, egli vuol bene alla madre e vuole restare legato a lei. Nel momento in cui alla sua mente affiora l’idea che quando la madre morirà lui sarà libero, ecco che egli sviluppa l’angoscia di avere un tumore o un infarto in atto o di aver contratto l’HIV nell’ultimo contatto sessuale avuto con una ragazza. La paura di perdere la madre e di perderla per suo stesso desiderio, lo porta a sentirsi minacciato della perdita del legame più importante e minacciato di abominio per il pensiero che ha osato formulare. La paura di ammalare, di soffrire e di morire ha ritorto contro di lui il pensiero distruttivo. A questo modo
1. la madre è salva dal suo desiderio di morte;
2. egli, intimorito, è di nuovo sotto il controllo del suo vecchio sistema morale, e torna ad essere il figlio devoto che è sempre stato.
Un altro esempio: un caso di agorafobia.
Una donna vive in un regime di asservimento nei confronti della famiglia acquisita: passa gran parte del suo tempo a gestire la vita fisica ed emotiva del marito e dei figli, nonché le faccende domestiche; ma, più o meno nell’inconscio, se ne sente soffocata e a tratti offesa. Nonostante il suo sacrificio, né il marito né i figli, né tanto meno i suoceri, le riconoscono dei meriti e la trattano con rispetto; e la nostalgia di ciò a cui ha rinunciato (un vecchio amore, un percorso di studi o di carriera, l’indipendenza…) la incalza sempre di più. Guidando la macchina, un giorno, ha la visione di perdere il controllo del veicolo e di investire e uccidere persone innocenti. Ne deduce la sua inaffidabilità. Da quel momento sviluppa la paura delle auto, della velocità e degli spazi aperti, che consentono movimento, corsa, velocità, libertà. Anche in questo caso il sintomo ha una funzione precisa. L’agorafobia di questa donna ha ottenuto, come l’ipocondria del ragazzo del caso precedente, due risultati:
1. i familiari sono salvi dall’aggressività della donna; perché
2. la donna si sente inaffidabile e pericolosa, quindi si pone sotto la tutela di persone ritenute “affidabili”.
Dunque la fobia ha segnalato al soggetto che la base della sua sicurezza era minacciata e lo era da lui stesso. Il ragazzo identifica la sua sicurezza nell’amore per la madre, la donna nella devozione alla famiglia. L’ansia ha segnalato loro che questa base sicura era minacciata, e che erano loro stessi, coi loro pensieri, a mettere a rischio l’equilibrio del sistema.
Il fobico ha dunque paura nel momento in cui vede minacciata la base della sua sicurezza (il “sistema” dentro il quale vive); e maggiormente ha paura se intuisce che è lui stesso, coi suoi desideri conflittuali, più o meno coscienti, a minacciare gli elementi di base della sua vita. Egli prova paura e la paura inibisce e blocca la sua volontà, responsabile dell’attentato alla sicurezza.
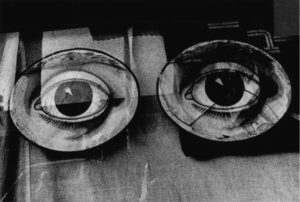 In un senso lato e sempre più complesso quanto più il soggetto è adulto, l’ansia deriva dalla capacità di mettere in relazione tre elementi intrinseci: 1) le intenzioni soggettive malevole più o meno esplicite nei confronti di una relazione fondamentale; 2) la colpa per quelle intenzioni; e 3) la privazione, per colpa, di quella relazione fondamentale.
In un senso lato e sempre più complesso quanto più il soggetto è adulto, l’ansia deriva dalla capacità di mettere in relazione tre elementi intrinseci: 1) le intenzioni soggettive malevole più o meno esplicite nei confronti di una relazione fondamentale; 2) la colpa per quelle intenzioni; e 3) la privazione, per colpa, di quella relazione fondamentale.
Per capire appieno il fattore simbolico intrinseco ad ogni fobia bisogna però padroneggiare il campo della metafora: il giovane che desidera la morte della madre può provare ansia al diretto pensiero di quella morte, ma anche al pensiero dei momenti in cui egli è solo in casa, perché questi gli segnalano in modo differito il pensiero della solitudine, quindi della mancanza della madre. Allo stesso modo, egli potrà sviluppare una agorafobia e aver paura ogni volta che esce di casa da solo perché lo spazio aperto (il vuoto) e il suo procedere per le strade in perfetta solitudine gli suggeriscono in modo sempre più ampio e differito lo stesso concetto. Egualmente, se un giorno dovesse pensare al fatto che le persone anziane sono spesso soggette a morire di malattia, egli potrebbe sviluppare un’ipocondria attraverso il pensiero – ritorsivo – che lui stesso potrebbe morire molto prima della madre, e sviluppare allo stesso tempo una fobia per gli ospedali, i luoghi di degenza e magari gli aghi e altri strumenti medici.
Risulta ovvio, almeno a me, che più l’individuo è dotato di un’intensa emotività e allo stesso tempo di un ricco sistema di relazioni simboliche, più è facile che, da una parte, egli intuisca e individui le infinite conseguenze dei suoi pensieri e, dall’altra, che rischi di sviluppare un reticolo di ansie, fobie e ossessioni che contrassegnano la presenza, nel suo inconscio, di pensieri pericolosi.
La psicoterapia dialettica dell’ansia e delle fobie
Per porre un rimedio all’ansia patologica e alle fobie che si strutturano su di essa è allora necessario definire tre elementi fondamentali:
1. in cosa consiste la sicurezza di base di quell’individuo?
2. Cosa sta minacciando quella sicurezza?
3. Se l’attore della minaccia è lui stesso, di che natura è il conflitto che lo oppone alla sua base affettiva, sociale, valoriale? In sintesi: per quali motivi egli ama e odia il sistema di valori e di certezze che lo sostiene come essere affettivo e sociale?
Fatta l’analisi di questi elementi, occorre allora trovare delle soluzioni nella forma della mediazione. La psicoterapia diventa allora una raffinata arte dialettica della mediazione.
Il ragazzo del primo esempio può separarsi dalla madre senza desiderarne la morte? La donna del secondo esempio può allentare la morsa dei doveri domestici o anche diventare un’attrice o una manager senza attaccare tutti i suoi legami?
In sostanza: è possibile essere liberi e allo stesso tempo non peccare di slealtà, non rinnegare gli elementi di fondo della propria intima umanità?
Si tratta, dunque, di porre delle mediazioni all’interno di un conflitto psicologico: il conflitto fra il bisogno affettivo, base della sicurezza psicologica di ogni individuo, e il bisogno egocentrico di autonomia personale.
Viviamo in un’epoca in cui questo conflitto è sempre più vivo: ogni individuo pretende per sé una chance in più di quelle che la vita ha concesso ai suoi genitori, vuole crescere al di sopra della propria classe di appartenenza, vuole sentirsi libero di muoversi fra diverse realtà sociali e morali, vuole avere ciò che perlopiù non è concesso, talvolta fino all’inflessibile perseguimento del mito della libertà assoluta. Questa poderosa spinta motivazionale (alimentata dalle ideologie sociali e dalla sempre più universale vergogna di impotenza) genera un’infinità di conflitti interiori e relazionali che esitano nelle due grandi psicopatologie del mondo contemporaneo: l’ansia patologica (col correlato attacco di panico) che è l’effetto della paura di perdere la propria base sicura; e la depressione, che è invece l’effetto del senso di colpa per l’idea di aver distrutto con le proprie mani quella base.
Il percorso di conquista di una libertà matura è lungo e difficile. Durante il cammino, più volte si può rischiare di eccedere nella trasgressione e nel conflitto e di conseguenza, per frenare questo rischio, si possono attivare sintomi psicopatologici. I sintomi, abbiamo detto, hanno la funzione di limitare l’attacco ai legami fondamentali e quindi il danno al proprio stesso Io e al sistema cui quell’Io appartiene. Non di meno, non mediati dalla coscienza, i sintomi psicopatologici possono essere intollerabili.
A questo livello, quando la sintomatologia è forte e franca, non v’è alcuna contraddizione nel fare uso di psicofarmaci – per placare l’intensità intollerabile della sofferenza – e allo stesso tempo lavorare per la presa di coscienza dei conflitti sottostanti al sintomo. Come allo stesso modo è legittimo non farne uso, purché si sia consapevoli che l’angoscia non sopita può essere estrema, senza requie e destabilizzante.
Il risultato da ottenere non è la semplice alterazione dello stato mentale in atto (cosa raggiungibile oggi con l’uso di sostanze chimiche farmacologiche e domani con la neuroingegneria), ma è piuttosto il cambiamento della struttura dell’Io, nel senso di accrescere l’abilità della coscienza a individuare e mediare i conflitti affettivi e valoriali che nascono all’interno della personalità.
Alla fine è l’attrezzatura della coscienza e una sua certa fluida coerenza a determinare se un individuo sarà vittima di un sistema psicopatologico o se invece sarà in grado di individuare i propri nuclei conflittuali gestendoli fino alla loro risoluzione.
Percorso bibliografico dialettico
La semplicità della tesi che ho sin qui esposto non deve trarre in inganno. Essa è il risultato di decenni di ricerche effettuate all’interno di quella che oggi si chiama Psicologia dialettica.
Nella mia opera scientifica pubblicata su materiale cartaceo ho documentato questa ricerca in molti libri; quelli che maggiormente interessano le dinamiche dell’ansia, dell’attacco di panico, delle fobie e della depressione sono questi:
Uscire dal panico (2000)
Volersi male (2002)
La logica dell’ansia (2008)
A viso aperto (2009)
La vita è un sogno (2018)
Nicola Ghezzani
Psicologo clinico, psicoterapeuta
formatore alla psicoterapia
Contattalo con un messaggio su WhatsApp al 333 999 4797
o per e-mail: nic.ghezzani@gmail.com
Indirizzo Skype: nicola.ghezzani.psicologo
- Candland D. K., The ontogeny of emeotional behaviour, in Moltz H., The ontogeny of vertebrate behaviour, New York, 1971; Miller N. E., Learning of visceral and glandular responses, in Science, CLXIII, 434, 1969. Vedi anche Reynolds V. (1976), La biologia dell’azione umana, Mondadori, Milano, 1978. Come si sa questa è, in sintesi, la tesi anche di John Bowlby.
- Nella mia opera scientifica ho documentato questa ricerca in molti libri; quelli che maggiormente interessano le dinamiche dell’ansia e dell’attacco di panico sono i seguenti: Uscire dal panico (2000); Volersi male (2002); La logica dell’ansia (2008), A viso aperto (2009), La vita è un sogno (2018), editi da Franco Angeli.