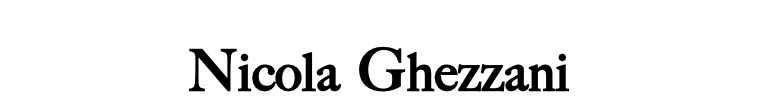Intervista sull’Alta Sensibilità
di Michele Razzetti per GQ
Dott. Ghezzani, come potremmo spiegare a un pubblico di non esperti cosa significa alta sensibilità?
 L’alta sensibilità è un tratto genetico che si esprime sin dalla nascita, ma è meglio osservabile a partire dai due o tre anni di vita. Sin dai primi mesi, i bambini altamente sensibili mostrano di avere temperamenti diversi sia dalla norma che fra di loro: alcuni sono contemplativi e silenziosi, altri affettivi e obbedienti, altri reattivi e irritabili, altri si muovono in continuazione.
L’alta sensibilità è un tratto genetico che si esprime sin dalla nascita, ma è meglio osservabile a partire dai due o tre anni di vita. Sin dai primi mesi, i bambini altamente sensibili mostrano di avere temperamenti diversi sia dalla norma che fra di loro: alcuni sono contemplativi e silenziosi, altri affettivi e obbedienti, altri reattivi e irritabili, altri si muovono in continuazione.
Dunque esistono differenze genetiche che si manifestano da subito, per poi andare incontro a una maturazione progressiva già nella prima infanzia, esprimendosi in tipi psicologici differenti. Che esista una base genetica è ormai dimostrato dagli studi longitudinali sul temperamento, come quelli di Chess & Thomas e Jerome Kagan, effettuati su centinaia di bambini dalla nascita fino all’adolescenza, e dagli studi specifici di Arthur ed Elain Aron e delle centinaia di ricercatori sparsi nel mondo accademico fra cui Michael Pluess, Jay Belsky, Bianca Acevedo, Francesca Lionetti. Un’ulteriore prova è stata fornita dalla Genetica comportamentale, in particolare da Robert Plomin.
L’alta sensibilità è caratterizzata, sin da bambini, dai tre/quattro anni in poi, da elevata sensibilità morale (questi bambini sono molto turbati se assistono a ingiustizie o se le subiscono in prima persona), restano incantati dalla musica, anche dal suono puro, dal movimento armonico di corpi variopinti o da vasti scenari naturali, si ritirano dalla socialità se è prepotente, frustrante o semplicemente eccessiva; da più grandicelli fanno domande molto complesse per la loro età, talvolta di carattere scientifico, talaltra di carattere filosofico ed esistenziale.
Spesso di fronte a un bambino sensibile sano un adulto ha la sensazione che sia un bambino “speciale”.
L’alta sensibilità è una dote, non un handicap, ed è importante che i genitori sappiano distinguere questa qualità per essere sempre al passo coi loro figli.
Molte persone lo sono e magari neanche lo sanno, quali sono i segni tipici di una persona dall’alta sensibilità?
 I segni sono molti, ma piuttosto sottili.
I segni sono molti, ma piuttosto sottili.
Innanzitutto, un certo senso estetico e un sentimento intimo di piacere sensoriale e di gioia di vivere. Le persone altamente sensibili sono in genere più consapevoli degli altri della bellezza, dell’armonia e di ciò che può procurar loro piacere; sia da bambini che poi da adulti sono spesso abili nelle arti, nella musica e negli sport armonici.
In secondo luogo, l’empatia e la sensibilità morale: le persone altamente sensibili sono più in grado di percepire gli stati d’animo altrui e ciò che si dovrebbe fare per migliorare un ambiente sociale; e la maggior parte di esse trova naturale essere coscienziosa, morale e preoccupata per la giustizia sociale. Riflettere sulle conseguenze delle azioni porta generalmente a porsi domande di questo tipo: “Perché quella persona ha agito in quel modo?”, “Cosa accadrà se qualcuno non interviene?” o “E se tutti agissero in questo modo che cosa accadrebbe?” o anche “Io non potrei fare mai questa cosa riprovevole!”. Ciò talvolta rende le persone sensibili problematiche e tristi; talaltra le può fare apparire altezzose e superbe se esprimono ad alta voce i loro giudizi.
Un’altra loro qualità è la sensibilità naturalistica: si trovano a proprio agio con piante, animali, oggetti o in qualsiasi altra situazione ambientale che richieda la comprensione di segnali non verbali. Godono del mare, delle montagne, del cielo stellato in un senso non solo fisico, ma anche contemplativo. Sanno stare in tacita compagnia con cavalli, cani, gatti, uccelli e altri animali domestici, ma amano e ammirano anche gli animali selvatici. Nelle situazioni di contemplazione naturalistica possono stare da sole con la natura e con i propri pensieri per ore intere.
Un’altra caratteristica è ancora l’alta emotività. Sia nei casi di sensibilità morale, che di sensibilità generale gli individui sensibili vengono investiti da forti cariche emotive. Da bambini tendono a piangere o a essere visibilmente turbati e paralizzati e sono spesso percepiti come timidi e troppo emotivi; da ragazzi arrossiscono o hanno esplosioni di ira o sono percepiti come poco adattati; da adulti sanno di doversi controllare allontanandosi dallo stimolo. Quasi tutti riferiscono di commuoversi facilmente e talvolta di piangere: e questa, se valorizzata, rappresenta una sorta di innata “leadership emotiva”.
Gli individui altamente sensibili sono anche altamente intuitivi e creativi, ciò vuol dire che perdono molto tempo a fantasticare, hanno idee e sensazioni improvvise che non sanno da dove provengano; spesso sono molto originali, fanno progetti complicati, che non sempre sono realistici.
Infine, generalmente riferiscono di possedere un orientamento religioso o filosofico e una vita interiore ricca e complessa, nonché di fare sogni molto vividi.
Come vive una persona di questo tipo nella società contemporanea?
 Il mondo attuale ha due caratteristiche del tutto incompatibili con la natura delle persone altamente sensibili: è superficiale e, soprattutto, è fondato sulla forza e sulla sua esibizione, non sulla moralità e l’intelligenza. Inevitabilmente solo una parte delle persone sensibili supera l’infanzia e l’adolescenza indenne. In una buona percentuale questi individui appaiono timidi, isolati, disadattati; moltissimi sviluppano una psicopatologia.
Il mondo attuale ha due caratteristiche del tutto incompatibili con la natura delle persone altamente sensibili: è superficiale e, soprattutto, è fondato sulla forza e sulla sua esibizione, non sulla moralità e l’intelligenza. Inevitabilmente solo una parte delle persone sensibili supera l’infanzia e l’adolescenza indenne. In una buona percentuale questi individui appaiono timidi, isolati, disadattati; moltissimi sviluppano una psicopatologia.
Non sempre il mondo è così ostile. Il problema è che “noi” – voglio adoperare la prima persona plurale perché io stesso mi includo in questa categoria – siamo individui molto complessi. Non sempre è facile avere a che fare con noi, sia per gli adulti che per i coetanei. Il nostro tratto di sensibilità spesso comporta che siamo cauti, introversi e bisognosi di più tempo da passare soli. Altre volte siamo spontanei ed esuberanti e non sopportiamo restrizioni. Poiché le persone prive di questo tratto (la maggioranza) non lo capiscono, ci vedono timidi, deboli o – peccato gravissimo – asociali. Altre volte ci percepiscono invece come troppo emotivi ed eccessivi. Altre volte ancora, quando ci ritiriamo e diamo giudizi morali, come altezzosi e superbi.
Temendo simili etichette, cerchiamo di essere come gli altri, con il risultato che ci creiamo un “falso Sé”, vale a dire una maschera pesantissima da portare, o di socializzarci a forza e di sentirci sovraccarichi di stimoli e di impegni e quindi stressati. E allora le nostre reazioni esasperate o di ritiro assoluto ci fanno bollare come nevrotici o pazzi, prima dagli altri e poi da noi stessi.
La cultura machista rende la sensibilità più complessa per gli uomini?
 La cultura maschilista crea un danno non solo ai giovani maschi sensibili, ma anche alle giovani femmine.
La cultura maschilista crea un danno non solo ai giovani maschi sensibili, ma anche alle giovani femmine.
Nei maschi ovviamente quella cultura tende a inibire o a far occultare la propria sensibilità e profondità, quindi genera le ferite traumatiche tipiche della stigmatizzazione: se non si nasconde o non si mistifica, il giovane maschio sensibile ed emotivo può essere giudicato una “femminuccia”; oppure un “noioso” se è introverso, riflessivo e profondo nei ragionamenti; o anche un “superbo” se si sente o mostra di essere intellettualmente superiore agli altri (e di solito lo è).
Altre volte però il giovane maschio, mortalmente ferito dalle denigrazioni e dalle umiliazioni, può caricarsi di risentimento e diventare una persona crudele e vendicativa. Nel punto di passaggio fra l’innocenza e la crudeltà abbiamo quel tipo di artisti, come Francis Bacon o Antonin Artaud, che pur mostrando la crudeltà in ogni suo aspetto, lo fanno solo nella loro opera, restando di fatto persone profondamente empatiche e buone. Talvolta però l’ipersensibile, traviato sin dall’infanzia, e reso ottuso dall’ignoranza, può scivolare per la via della crudeltà agita. Alcuni dei mostri della storia, come François de Sade o Adolf Hitler, sono stati dei bambini altamente sensibili.
Ma anche le ragazze vengono danneggiate da questa cultura, perché assorbono il codice maschilista e, per essere adeguate al modello dominante, rifiutano i ragazzi sensibili e complessi, che sono proprio quelli più le capiscono e meglio potrebbero amarle, finendo per scegliere individui mediocri ed esibitivi. Altre volte – oggi è un fenomeno frequente – assumono esse stesse caratteri machisti duri e prepotenti e diventano delle “bulle” e delle sadiche umiliatrici e spregiatrici dei deboli.
Dott. Ghezzani, secondo lei quale approccio psicoterapico è più indicato per le persone sensibili che sviluppano psicopatologie (e quali sviluppano in genere)?
Nell’articolo del 2006 “The clinical implications of Jung’s concept of Sensitiveness”, la psicologa americana Elaine Aron fa un’annotazione fondamentale: le persone altamente sensibili, dice, «costituiscono circa il 20% della popolazione, ma potrebbero rappresentare il 50% o più di coloro che cercano il nostro aiuto professionale. Inoltre, a causa della loro natura riflessiva e dei sogni più vividi, è molto probabile che essi scelgano un approccio terapeutico profondo. Quindi sono spesso negli studi degli psicoanalisti junghiani e hanno bisogno di solide spiegazioni di come l’alta sensibilità innata interagisca con l’ambiente per produrre gli adulti che diventeremo. Quindi dobbiamo esplorare l’intera gamma delle implicazioni cliniche della sensibilità iniziando dai modi in cui il concetto può contribuire alla nostra comprensione iniziale delle difficoltà dei nostri pazienti».
A onore del vero, le percentuali citate da Aron possono essere corrette al rialzo: nella mia esperienza clinica almeno l’80-90% dei pazienti è costituito da persone con tratti di alta sensibilità, spesso accompagnata da un alto potenziale intellettivo.
La risposta alla domanda su quale sia l’approccio psicoterapeutico più indicato per una persona altamente sensibile richiede una risposta complessa. Innanzitutto occorre non drammatizzare i sintomi, che spesso sono solo modi di funzionamento mentale: spesso ho visto diagnosi di autismo, di Asperger o di personalità schizoide applicate a persone che erano solo molto introverse o molte complesse sul piano intellettuale. In questi casi, la diagnosi errata e la somministrazione di psicofarmaci comportano un danno gravissimo. Ma non bisogna nemmeno sottovalutare i segni di ansia, soprattutto sociale, di depressione e di generico disadattamente alla vita.
Per le persone altamente sensibili esistono molte soluzioni terapeutiche adeguate: quelle formulate dalla mia psicoterapia dialettica, quelle formulate dalla scuola di Elaine Aron, nonché la psicoanalisi junghiana, la psicoterapia esistenziale, l’arteterapia, lo psicodramma.
Bibliografia dell’Autore
N. Ghezzani, Il dramma delle persone sensibili, FrancoAngeli Milano 2021.
N. Ghezzani, Persone sensibili in terapia, FrancoAngeli, Milano 2024.
N. Ghezzani, Volersi male, FrancoAngeli, Milano 2002.
E. Aron, Persone altamente sensibili, Mondadori, Milano 2011.
Puoi leggere la versione online dell’intervista qui: