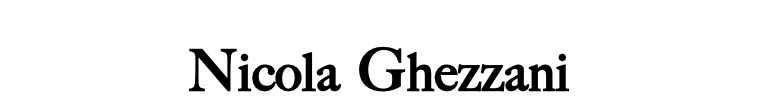La volontà di non guarire
Resistenze al trattamento
 Nell’attività di psicoterapia accade più spesso di quanto non si pensi che i progressi terapeutici ottenuti in una prima fase del trattamento si arrestino d’improvviso fino a incagliarsi del tutto. In un certo momento si aveva l’impressione che il rapporto fosse fluido e aperto e che tutto andasse a gonfie vele; poi, nelle sedute successive, la scena si rovescia: tutto appare immobile, il paziente si oppone in modo attivo o passivo e la terapia è impantanata in una bonaccia estenuante.
Nell’attività di psicoterapia accade più spesso di quanto non si pensi che i progressi terapeutici ottenuti in una prima fase del trattamento si arrestino d’improvviso fino a incagliarsi del tutto. In un certo momento si aveva l’impressione che il rapporto fosse fluido e aperto e che tutto andasse a gonfie vele; poi, nelle sedute successive, la scena si rovescia: tutto appare immobile, il paziente si oppone in modo attivo o passivo e la terapia è impantanata in una bonaccia estenuante.
La prima cosa da fare in questi casi è constatare che l’arresto della terapia è l’effetto di una volontà oppositiva inconscia; quindi, sulla base di questa osservazione, capire quale sia la motivazione recondita di questa volontà. Ebbene, l’esperienza clinica ci aiuta a capire che l’improvviso blocco s’è verificato poco prima di effettuare un passaggio cognitivo o comportamentale di grande importanza, o persino poco prima di poter intravedere una diversa e migliore organizzazione della personalità, quindi un modo diverso di gestire la vita. In sostanza, si è verificata quella che chiamiamo una “resistenza al trattamento”, un fenomeno di arresto che può manifestarsi in molte forme.
D’altra parte, per quanto le forme della resistenza possano apparire variegate e talvolta sconcertanti, il terapeuta può capirle in profondità, al punto da poterne fare una significativa semplificazione. La Psicoterapia Dialettica ci consente di capirle nella loro radicalità, riducendole a due forme essenziali. In tutta la pur complessa fenomenologia del rapporto clinico, le forme di resistenza si possono riassumere così: da una parte la resistenza dell’Io antitetico, dall’altra la resistenza del Super-io, che l’Io del paziente agisce contro il processo terapeutico, il più delle volte senza nemmeno rendersene conto.
Siamo ora in grado di dare una precisa definizione alle due forme di resistenza. La prima, poiché fa capo all’Io antitetico, la possiamo chiamare “resistenza antitetica” e, per semplificare, poiché spesso coincide con tratti caratteriali narcisistici la possiamo chiamare anche “resistenza narcisistica”; l’altra, collegata al Super-io, la possiamo chiamare “resistenza superegoica, e poiché per contro esprime con maggior evidenza le tendenze conservatrici e masochistiche della persona, la possiamo chiamare anche “resistenza masochistica”.
La resistenza antitetica
 Secondo la Psicologia Dialettica, l’Io antitetico costituisce la parte differenziativa e oppositiva della personalità, l’istanza della psiche incaricata di differenziare l’individuo consentendogli il dispiegamento delle sue qualità intrinseche. Allorché sia ferito da traumi e insidiato dall’angoscia di impotenza, diviene un Io antitetico oppositivo e organizza una difesa narcisistica. Pur di non essere modificato, si oppone alla guarigione. La difesa narcisistica impedisce la sintonia, l’integrazione affettiva, la gratitudine e quindi la guarigione.
Secondo la Psicologia Dialettica, l’Io antitetico costituisce la parte differenziativa e oppositiva della personalità, l’istanza della psiche incaricata di differenziare l’individuo consentendogli il dispiegamento delle sue qualità intrinseche. Allorché sia ferito da traumi e insidiato dall’angoscia di impotenza, diviene un Io antitetico oppositivo e organizza una difesa narcisistica. Pur di non essere modificato, si oppone alla guarigione. La difesa narcisistica impedisce la sintonia, l’integrazione affettiva, la gratitudine e quindi la guarigione.
Vediamo in che modo si manifesta la sua resistenza al processo terapeutico.
Un primo tipo di resistenza antitetica si esprime sotto forma di un atteggiamento perennemente scettico nei confronti delle interpretazioni e delle spiegazioni che lo psicoterapeuta fornisce; un atteggiamento ipercritico, un’espressione di incredulità, ora delusa e addolorata, ora sfottente, talora persino un tono aggressivo nei confronti della persona del terapeuta. Questa tipo di resistenza si presenta spesso quando i pazienti, particolarmente adolescenti e giovani, si sentono costretti a sottoporsi al trattamento per placare le ansie dei genitori o per ottenere la loro accondiscendenza e qualche vantaggio di ordine secondario. Lo stesso accade coi giovani tossicodipendenti, spinti alla terapia da un familiare. Consapevole dell’inganno, il paziente resiste. In questi casi il più delle volte l’opposizionismo antitetico si declina nei modi di un narcisismo “overt”, ossia conscio e esplicito.
In altri casi si accampano critiche più o men articolate nei confronti del metodo del terapeuta. L’interpretazione è considerata insufficiente e banale oppure assurda e incredibile, la spiegazione è troppo didascalica o troppo complicata, il metodo clinico è di conseguenza troppo semplicistico o troppo intellettuale. Un paziente chiede un’analisi “più profonda”, un altro – più spesso – “esercizi pratici mirati alla soluzione”. Questo tipo di resistenza compare di solito nella terapia di soggetti adulti, i quali avviano il trattamento di loro iniziativa e con apparente collaborazione. In questo caso la resistenza è l’espressione di un opposizionismo che nasconde una fobia imbarazzante: la paura di essere influenzati. Si tratta in questo caso di persone che da un lato presentano un’elevata stima di sé, dall’altro un segreto sentimento di insicurezza e di ontologica insufficienza. Più si sentono minacciate dall’angoscia di essere sopraffatti dal sentimento, dall’intelligenza o dal carattere del terapeuta, più si oppongono. In questi casi si manifesta un narcisismo “covert”, inconscio e implicito.
Nella resistenza antitetica è dunque palese la prevalenza di un elemento narcisistico. Angosciato da un sentimento d’impotenza e quindi dal rischio di essere dominato, il paziente si costruisce una maschera di vittimismo rivendicativo o di superba arroganza, che oppone come un muro a qualunque tentativo terapeutico di ordine affettivo o intellettuale.
Nel 1937 Freud scrisse il breve saggio “Analisi terminabile e interminabile” nel quale si interrogava sull’ultima resistenza alla guarigione. In questo scritto straordinario, Freud afferma che l’ultima difesa del paziente non è altro che l’affioramento in piena luce della dura pietra del “narcisismo primario”, il quale ha un fondamento naturale, e come tale non è in alcun modo “addomesticabile”. «Abbiamo spesso l’impressione – dice – che con il desiderio del pene (femminile) e con la protesta virile (maschile), dopo aver attraversato tutte le stratificazioni psicologiche, siamo giunti alla roccia basilare, e quindi al termine della nostra attività. Ed è probabile che sia così giacché, per il campo psichico, quello biologico svolge veramente la funzione di una roccia basilare sottostante. In definitiva il rifiuto della femminilità non può essere che un dato di fatto biologico, un elemento del grande enigma del sesso».
Per “rifiuto della femminilità” Freud intende rifiuto di interagire con gratitudine con l’analista e nei rapporti umani in genere. E quando usa il termine “narcisismo primario” intende un istinto aggressivo ed auto-difensivo universale che riguarda sia le donne che gli uomini.
Oggi il concetto di “narcisismo primario” è stato superato non solo dalla psicoanalisi successiva a Freud e dalle altre psicoterapie, ma anche dalla ricerca scientifica. Dagli studi di Harlow e Spitz fino a quelli di Bowlby, dalla ricerca sull’infanzia fino alla scoperta dei neuroni specchio, che dobbiamo a Giacomo Rizzolatti e alla sua equipe, è chiaro che l’uomo è una specie sociale e socievole e che se avesse inserito al centro del suo cervello un “narcisismo primario” non sarebbe sopravvissuto più di due o tre generazioni. Inoltre, molti di noi sono consapevoli che piuttosto che costituire il limite “sine qua non” della psicoterapia, proprio la risoluzione di questo “narcisismo primario”, cioè di questa “volontà di non guarire”, è il vero punto focale di una cura condotta fino in fondo.
Per dare un nome a questa “volontà di non guarire”, a questo impulso che spinge i pazienti a lasciare il loro terapeuta a un passo dal benessere, che li spinge a confliggere con lui, o ad accampare un milione di sintomi piuttosto che trasformare il rapporto clinico in una guida al benessere esistenziale possiamo comunque usare il concetto di “narcisismo” (non “primario”). C’è una parte inconscia in ciascuno di noi che si oppone al legame, alla socialità intima, alla gratitudine e che non vuole darla vinta a chiunque ci ami, ci aiuti e si prodighi per noi. Questa parte coincide con un narcisismo universale, tributario dell’angoscia di essere sottomessi e in ultima istanza di non essere più noi stessi, magari aggressivi, magari malati, ma noi stessi.
Io adopero per convenzione e per semplicità il concetto di narcisismo, ma, come ho detto, lo ho ricodificato come “Io antitetico” e, nello specifico, come “alienazione dell’Io antitetico”. Secondo la Psicoterapia Dialettica, l’Io antitetico è la parte dialettica e oppositiva della personalità, la cui funzione naturale è di fornirci l’impulso allo sviluppo di una personalità autonoma, espressiva delle nostre qualità innate. Esso può andare incontro a distorsioni fin dall’infanzia e trasformarsi in quel demone oppositivo che è appunto il narcisismo, il quale in questo senso risulta essere una componente patologica potenzialmente universale. Oggi il mondo è frammentato e animato da egoismi, competizioni e conflitti proprio per lo sviluppo abnorme e universale di queste parte della personalità, sia a livello individuale che dei popoli. Piuttosto che produrre vocazioni personali, questa parte produce ormai solo narcisismo, odio reciproco, invidia e competizione.
Anche in sede clinica è fondamentale tener presente questa componente oppositiva, questa “parte narcisistica” potenzialmente presente in ciascuno di noi. Le psicoterapie moderne, purtroppo, nello sbilanciarsi verso la “terapia breve” o addirittura “istantanea” hanno perso di vista questo narcisismo inconscio, questo Io antitetico, che è il principale e vero ostacolo al benessere personale.
La volontà di non guarire, se non si presenta sin dalle prime sedute come disturbo narcisistico conclamato, appare sempre e soltanto nel corso di un lungo periodo di analisi, quando ai primi miglioramenti segue la necessità di vivere gli affetti e saper esprimere gratitudine. È all’esperienza della propria vulnerabilità e della necessità di sperimentare tenerezza e compassione verso di sé e verso gli altri che il paziente si oppone con orrore; ed è solo la durata del rapporto e la profonda conoscenza del paziente che permette al terapeuta di condurre la psicoterapia fino in fondo.
La resistenza superegoica
 Il Super-io media e integra nell’individuo l’appartenenza a un sistema sociale e valoriale cui deve devozione ed obbedienza. La resistenza superegoica, la resistenza che il Super-io oppone alla terapia, è una resistenza che mette in gioco la lealtà invisibile del paziente al sistema cui appartiene, si esprime quindi in una miscela di conservatorismo ossessivo e di masochismo morale.
Il Super-io media e integra nell’individuo l’appartenenza a un sistema sociale e valoriale cui deve devozione ed obbedienza. La resistenza superegoica, la resistenza che il Super-io oppone alla terapia, è una resistenza che mette in gioco la lealtà invisibile del paziente al sistema cui appartiene, si esprime quindi in una miscela di conservatorismo ossessivo e di masochismo morale.
Vediamo i casi più frequenti di questo tipo di resistenza.
Il più frequente è quello in cui il paziente appare come “il paziente migliore del mondo”, capace di una collaborazione aperta e attiva, che sembra manifestare un autentico desiderio di capire, migliorare, guarire. Che si tratti però di una resistenza quanto mai tenace è dimostrato dal fatto che, mentre il processo di comprensione della storia interiore e delle situazioni sociali disfunzionali procede e sembra essere acquisito viene acquisito, nella prassi esistenziale quotidiana non avviene alcun cambiamento. Di fronte a queste impasse, il terapeuta accorto sa che il suo paziente si sta avvalendo di una “razionalizzazione”, un processo cognitivo nel quale le interpretazioni vengono capite ma non avvertite a livello emotivo, quindi tanto meno vissute.
La resistenza superegoica assume innanzitutto una fenomenologia di tipo ossessivo. Una invisibile coercizione morale impedisce al paziente di accettare interpretazioni e avviare cambiamenti i quali sente, oscuramente, lo indurrebbero a violare un ordine morale: un “mandato” familiare, un ruolo sociale, una funzione cardine all’interno di un sistema affettivo, un valore “sacro” da non trasgredire. In questi casi è in gioco la “scrupolosità”: l’angoscia di danneggiare qualcuno – ovviamente una persona amata, ma anche chiunque si ponga come proprio simile – in conseguenza di un cambiamento di un atteggiamento personale o dell’intero stile di vita. Casi tipici: il padre di famiglia che non cede rispetto a un suo assetto sacrificale per poter continuare a sostentare la famiglia; una madre che subisce le angherie di un marito narcisista o antisociale per non danneggiare il figlio; un figlio che vive una vita “perfetta” o “normale” per paura di deludere i genitori.
In altri casi, la scrupolosità è animata dall’angoscia di poter provocare un danno irreversibile a se stessi più che ad altri. Allora, la resistenza è intimamente connessa all’idea ossessiva di ospitare nel proprio inconscio pulsioni asociali e intenzioni malvage. Per esempio, il paziente teme che se lasciato libero dalla nevrosi potrebbe abbandonarsi a trasgressioni sessuali o a violenze interpersonali o a delinquenza morale. Dobbiamo parlare in questo caso di una “fobia della cattiveria” che costituisce il nucleo di queste resistenze. In una tipologia analoga, possiamo individuare una “fobia della libertà”: il paziente teme, se fosse libero dalla patologia, acquisirebbe un’opzione di scelta fra le polarità antitetiche che lo renderebbe di fatto amorale. Restando un “bravo paziente” e inibendo ogni ulteriore conoscenza di sé, la persona in terapia scongiura così l’avvento della temute parti malvage o quantomeno amorali.
Un altro nucleo di resistenza superegoica riguarda la “fobia della debolezza”. Si tratta di una fobia evidente ancora una volta nei pazienti ossessivi, che, pur sconvolti dalla loro presunta cattiveria, sono non meno terrorizzati dall’idea di potersi scoprire sensibili, quindi inermi di fronte alla prepotenza altrui. La fobia della debolezza è però sistematica nelle personalità isteriche, per le quali il passare dalla dipendenza fusionale con un partner al rigetto della relazione, quindi dall’amore all’odio, dalla tenerezza al sadismo, è espressione di un’identità inafferrabile, quindi potente, perché aperta ad ogni possibile libertà. Nel caso dell’isteria, il cambiamento terapeutico si arresta di fronte all’angoscia di una definizione irreversibile di sè, che appare insopportabile.
C’è da considerare infine la resistenza opposta dal bisogno inconscio di punizione e di riparazione, la cui azione va rubricata sotto il nome di “masochismo morale”. Anche in questo caso, come già nel caso del narcisismo, Freud è stato il primo a dare rilievo al fenomeno.
Nei “Tre saggi sulla teoria della sessualità” (1925), scrive: “Spesso si può riconoscere che il masochismo è nient’altro che una prosecuzione del sadismo rivolto verso la propria persona”. Il masochismo morale cui Freud fa cenno è la tendenza inconscia di alcuni soggetti a produrre, sia a livello soggettivo che nell’interazione con il mondo, un regime di vita doloroso o infelice, corrispondente ad un bisogno inconscio di soffrire, mortificarsi, punirsi, espiare. Ma anche in questo caso, come nel caso del narcisismo, Freud paga un pesante dazio alla teoria delle pulsioni: parla di una “masochismo primario” cioè di una tendenza naturale a soffrire, che farebbe parte della natura umana e nascerebbe con il neonato. Concetto anche questo disconfermato da ogni ricerca etologica, evoluzionista e neurobiologica. L’essere umano che vuole soffrire lo fa per un lento e profondo condizionamento interpersonale e sociale, del tutto innaturale. I centri del dolore e del piacere sono cooptati da aree neurobiologiche “apprese” (insegnamenti, ammonimenti, maltrattamenti, traumi ecc.) che fanno capo a ciò chiamiamo Super-io. Nel masochismo morale i sentimenti dolorosi soverchiano quelli edonici, piacevoli.
In che modo si manifesta il masochismo morale del paziente? In molti modi. Innanzitutto, egli non crede affatto di stare meglio, nonostante ciò venga segnalato da chi gli sta vicino. Lo nega caparbiamente, si sente in ansia se gli viene detto, talvolta si arrabbia. Poi, se si rende conto che in effetti sta meglio, viene preso dall’angoscia e dall’improvvisa irruzione di nuovi sintomi. Altrettanto spesso egli mantiene un regime di vita mortificante, o sentendosi invalido, o dedicando la vita al solo lavoro, alla conduzione domestica e familiare, o ad opere altruistiche. Spesso ha una dipendenza irresolubile dagli psicofarmaci e mantiene il rapporto col terapeuta non per una sana esigenza di ottenerne una guida al benessere esistenziale (salutogenesi), parallela e successiva al processo di guarigione, quanto per un sottile panico di poter precipitare ancora nel malessere.
È chiaro che come il narcisismo dipende da una completa soggezione dell’Io all’Io antitetico oppositivo, allo stesso modo il masochismo morale deriva da una completa soggezione dell’Io a un Super-io punitivo.
Cosa vuol dire che la persona è sottomessa a un Super-io punitivo?
Vuol dire che la sua mente è abitata da un oscuro senso di colpa, dall’idea che alla propria felicità possa coincidere l’infelicità o il danno di qualcun altro, o il semplice turbamento di un equilibrio “morale” secondo il quale a lui è destinata una vita di dolore. Egli avverte il “diritto” a essere felice, a stare in un presente libero dal patimento, ma lo legge come un imperdonabile egoismo, ma lo legge come un imperdonabile egoismo, in un mondo pieno di sofferenza, dominato dalla violenza e dalla sopraffazione.
Talvolta si condanna alla sofferenza avendo o avendo avuto un parente o un sistema familiare sofferenti, dai quali emanciparsi implicherebbe il tradimento della suddetta regola di proscrizione dell’egoismo.
Condizionato da un senso di giustizia inflessibile, si attribuisce colpe che ha e soprattutto colpe che non ha, e fa della sua vita il compenso doloroso di un mondo interamente spostato sull’asse del godimento narcisistico.
Guarisce solo effettuando due passaggi. Il primo è portare il suo masochismo morale a livello di coscienza e comprendere che giusto e sano è solo il compito morale vocazionale, ossia quello che dona soddisfazione. Il secondo è ammettere che la sua vita è già regolata da una giustizia naturale, più profonda delle regole apprese, una giustizia naturale che gli ha donato i centri del piacere, funzionali al dispiegamento delle sue qualità e a compensarlo della fatica di vivere.
La paura dell’abbandono
 Uno dei miti più pervasivi del mondo contemporaneo è quello dell’autosufficienza, una condizione psicologica secondo la quale l’individuo sano è un’unità monadica, chiusa in se stessa e libera da bisogni intrinseci di interdipendenza. Questo mito ha invaso anche i modelli medico-psicologici e i paradigmi di salute. In conseguenza di ciò, alcuni pazienti, presentano una resistenza paradossale. Nonostante gli evidenti benefici tratti dalla psicoterapia, accampano sintomi e malesseri indefiniti, di tipo ipocondriaco e inibitorio. Lo fanno a causa della paradossale paura di essere considerati guariti e pertanto allontanati dalla terapia. Essi temono la separazione non solo e non tanto dal terapeuta, quanto dall’esperienza conoscitiva e creativa che ha avuto luogo dentro di loro durante il percorso di terapia. Sentono di avere ancora bisogno del rapporto, ma non sanno perché.
Uno dei miti più pervasivi del mondo contemporaneo è quello dell’autosufficienza, una condizione psicologica secondo la quale l’individuo sano è un’unità monadica, chiusa in se stessa e libera da bisogni intrinseci di interdipendenza. Questo mito ha invaso anche i modelli medico-psicologici e i paradigmi di salute. In conseguenza di ciò, alcuni pazienti, presentano una resistenza paradossale. Nonostante gli evidenti benefici tratti dalla psicoterapia, accampano sintomi e malesseri indefiniti, di tipo ipocondriaco e inibitorio. Lo fanno a causa della paradossale paura di essere considerati guariti e pertanto allontanati dalla terapia. Essi temono la separazione non solo e non tanto dal terapeuta, quanto dall’esperienza conoscitiva e creativa che ha avuto luogo dentro di loro durante il percorso di terapia. Sentono di avere ancora bisogno del rapporto, ma non sanno perché.
Non si tratta necessariamente di una dipendenza; se avessimo di fronte una dipendenza dovremmo osservare sintomi acuti e, soprattutto, un conflitto intrapsichico contrassegnato da cariche emotive contraddittorie. Ma del conflitto, di emozioni intense e di sintomi non c’è più traccia. Ebbene, nel caso citato si tratta piuttosto dell’emergere di una esigenza misconosciuta: l’esigenza di dotarsi di un senso al di là di quello conferito dai sintomi, un senso – un nuovo significato – che coincida con una crescita personale. Temono, a causa di una loro personale fantasia di onnipotenza non di rado condivisa anche dal terapeuta, che raggiungere la guarigione significhi pervenire ad uno statuto di perfezione, statuto che implica l’autosufficienza, quindi l’ovvia e definitiva risoluzione del rapporto terapeutico. Tale risoluzione viene vissuta dal paziente come un drammatico abbandono a se stesso, per cui lamentandosi di nuovi sintomi e malori egli ottiene il risultato di dilazionare il momento fatale della separazione.
Ebbene, in molti di questi casi, per risolvere la resistenza è sufficiente ricalibrare il rapporto da “rapporto clinico” a “rapporto esperienziale”: i pazienti con quest’angoscia non riescono a nominare un’esigenza tabuizzata e censurata dalla cultura contemporanea, una cultura incentrata sul mito della guarigione “perfetta”, cioè della “restitutio ad integrum” e della completa autosufficienza. Il loro desiderio privo di parole è di avere un interlocutore competente, una guida, un mentore, forse anche un maestro, che consenta loro di proseguire la loro esperienza conoscitiva oltre la terapia, mantenendo attiva la funzione creativa e trasformativa che li ha accompagnati fino a quel momento. È sufficiente allora che il terapeuta nomini questa esigenza misconosciuta e dica che il rapporto non deve necessariamente cessare con la scomparsa dei sintomi, perché il paziente trovi sollievo e possa finalmente avviare la fase della “crescita personale” o, come direbbe Jung dell’”individuazione”. L’angoscia di una solitudine obbligata viene allora scongiurata dalla prosecuzione della relazione sotto questa nuova forma.
La paura del cambiamento
 Dall’analisi fatta fino ad ora risulta con evidenza che “la volontà di non guarire” è sola una formula provvisoria, la quale introduce il concetto, più aderente ai fatti, della “paura del cambiamento”: un vero e proprio terrore angoscioso di abbandonare il proprio equilibrio strutturale – per quanto doloroso esso sia – per avviare un’evoluzione che si teme possa rivelarsi peggiore del male originario.
Dall’analisi fatta fino ad ora risulta con evidenza che “la volontà di non guarire” è sola una formula provvisoria, la quale introduce il concetto, più aderente ai fatti, della “paura del cambiamento”: un vero e proprio terrore angoscioso di abbandonare il proprio equilibrio strutturale – per quanto doloroso esso sia – per avviare un’evoluzione che si teme possa rivelarsi peggiore del male originario.
In cosa consiste il presentimento del male da cui il paziente vuole assolutamente fuggire? In sintesi: nella oscillazione continua fra il terrore di rivelarsi debole e di cadere così in una “dipendenza sprovveduta” (come la chiamava Masud Khan) e il terrore opposto di rivelarsi cattivo, malvagio e distruttivo nei confronti tanto degli altri quanto di se stesso. Spesso le due fobia sono inestricabilmente confuse, o si rovesciano l’una nell’altra. Questo nucleo generativo sta al cuore di ogni psicopatologia e giustifica la mia convinzione che il sistema diagnostico di cui ci valiamo in psicopatologia non dovrebbe più essere né categoriale (DSM) né dimensionale (PDM), bensì “generativo” e “trasformazionale”. Il nucleo generativo del conflitto “buono-dipendente/cattivo-distruttivo”, oscillando, fa sì che la personalità vada incontro a molteplici trasformazioni strutturali.
Di questo ho parlato nell’articolo che puoi leggere qui: https://www.nicolaghezzani.it/psicologia-e-visione-delluomo/le-strutture-psicopatologiche/
La resistenza giusta
 Naturalmente non esiste solo la resistenza patologica del paziente disturbato nei confronti del terapeuta sano e ben orientato. Non poche volte il paziente ha ragione. Esiste una resistenza non patologica, sana, quindi “giusta”, che egli esercita nei confronti della terapia, senza tuttavia aver ben chiaro il perché. Accade ogni qual volta il paziente intuisce, ma non sa esprimere in modo chiaro e coerente, che il terapeuta sta commettendo un errore, o che esiste qualcosa di patologico nella personalità del suo curante, un disturbo che sta condizionando il rapporto. In alcuni casi è possibile persino che il paziente stia percependo in modo confuso l’inefficacia persecutoria dell’intero sistema o metodo di cura, che gli si mostra sbagliato in radice. In questo caso, la resistenza del paziente si oppone visceralmente a sottili distorsioni presenti sia nella personalità del terapeuta che nell’intero sistema della cura. Provo a dare un paio di esempi al riguardo, sperando di avere tempo per ampliare il discorso in futuro.
Naturalmente non esiste solo la resistenza patologica del paziente disturbato nei confronti del terapeuta sano e ben orientato. Non poche volte il paziente ha ragione. Esiste una resistenza non patologica, sana, quindi “giusta”, che egli esercita nei confronti della terapia, senza tuttavia aver ben chiaro il perché. Accade ogni qual volta il paziente intuisce, ma non sa esprimere in modo chiaro e coerente, che il terapeuta sta commettendo un errore, o che esiste qualcosa di patologico nella personalità del suo curante, un disturbo che sta condizionando il rapporto. In alcuni casi è possibile persino che il paziente stia percependo in modo confuso l’inefficacia persecutoria dell’intero sistema o metodo di cura, che gli si mostra sbagliato in radice. In questo caso, la resistenza del paziente si oppone visceralmente a sottili distorsioni presenti sia nella personalità del terapeuta che nell’intero sistema della cura. Provo a dare un paio di esempi al riguardo, sperando di avere tempo per ampliare il discorso in futuro.
Una forma di questa resistenza è relativa alla farmacoterapia. In un caso ci può essere una “farmacoresistenza”, in un altro una “farmacofobia”, che sono le più tipiche resistenze del paziente alla cura psichiatrica. In questi casi il paziente intuisce che la via farmacologica, se troppo meccanicistica e troppo esclusiva, può essergli di danno; quindi assume i farmaci i quali però non hanno alcun effetto (per mancanza di “compliance”), oppure ne ha paura e si rifiuta di assumerli. Ciò dipende dal fatto che la logica diagnostica del DSM (“Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders”, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) somiglia sempre più a un algoritmo che a una riflessione scientifica ed empatica finalizzata alla cura della mente umana. Cosa che fra l’altro va trasformando più di una generazione di psichiatri in uno sterminato esercito di terminali dell’A. I., l’Intelligenza Artificiale: i processi analitici e decisionali del DSM seguono infatti una logica categoriale che adatta il paziente allo strumento diagnostico e infine al farmaco; non il contrario. Di conseguenza, il paziente si sente trattato da “cosa”, da “oggetto”, e resiste, senza riuscire a mettere a fuoco il perché.
Una seconda forma di resistenza sana riguarda una certa “qualità” dell’intervento psicoterapeutico. Oggi, in Italia, esiste una legge sull’esercizio della psicoterapia, una legge meritoria che ha normato l’esercizio della professione vincolandola ad una formazione universitaria articolata e complessa. Tuttavia, per quanto dettagliata, la legge non non ha impedito che un reticolo di lobbies, prassi e regole implicite si impossessasse della formazione, conferendo alle scuole e alle istituzioni di tirocinio un potere assoluto. Catturato in questo reticolo di poteri, il giovane psicologo rischia di essere letteralmente abusato in vari modi dai suoi formatori. Genogrammi che si pongono di fatto come terapie di gruppo non autorizzate, psicoterapie personali con didatti imposti dalla scuola, tirocini non pagati che funzionano come sistemi di umiliazione e asservimento si rivelano di fatto come situazioni traumatiche. E, come sappiamo, non esiste una persona traumatizzata che possa essere di aiuto a un’altra persona sofferente quanto o più di lui.
Ovviamente non mi riferisco a tutti i percorsi di formazione. La gran parte delle scuole sono serie e affidabili. Lo so per conoscenza ed esperienza diretta. Tuttavia, non esistendo la possibilità di controllare caso per caso i possibili abusi all’interno della formazione, per garantire la correttezza della procedura basterebbero alcune cautele di ordine formale: per esempio, il tirocinio medico psichiatrico viene pagato e inserito in strutture pubbliche, per contro quello dei candidati psicoterapeuti è gratuito e affidato a istituzioni e associazioni di ogni tipo: dovrebbe invece essere equiparato a quello medico e pagato. Aggiungo: a uno psichiatra non viene chiesto di mettere in pubblico – in gruppi improvvisati di colleghi – la vita intima propria e della sua famiglia, a uno psicologo sì: lo si fa per esempio nella pratica dei genogrammi. A uno psichiatra non viene imposto “il” professionista con cui effettuare una psicoterapia personale, a uno psicologo sì; con l’effetto di violare il vincolo di scelta e di fiducia che deve intercorrere fra curante e curato. Si tratta di errori di formazione che sconfinano nell’immorale. E il rispetto reciproco è in assoluto il primo fattore di formazione umana; quindi lo è anche nella formazione alla psicoterapia.
Il percorso formativo dello psicoterapeuta non può non avere un impatto sulla qualità del rapporto che egli avrà col paziente. La sofferenza introiettata e sopportata in forma di autocontrollo ossessivo o di masochismo può indurre una pratica improntata a un metodo rigido e impersonale o a un’enfasi sulla rassegnazione e la rinuncia, oppure al contrario all’idealizzazione dell’egoismo e della trasgressione.
In sintesi, la scorrettezza del percorso formativo può indurre deformazioni nel carattere del terapeuta, con l’effetto che né il paziente né il terapeuta hanno modo di capire quanto il paziente si sente in pericolo non per il suo disturbo ma per quello del suo terapeuta. Quindi nessuno dei due ha modo di capire che la resistenza del paziente potrebbe rispondere all’intuizione sana, ancorché confusa, di un difetto nello stesso sistema della formazione e della cura.
Bibliografia
Di narcisismo e resistenze narcisistiche ho parlato nei libri: L’ombra di Narciso e Relazioni crudeli.
Di masochismo morale ho parlato nel libro nel libro Volersi male.
Per la teoria della classificazione diagnostica leggi La specie malata.
Per la classificazione diagnostica della psicoterapia dialettica puoi leggere anche questo articolo, cliccando qui